In riferimento
per le successive
LA CASA DELLA
LIBERTA’
Dopo
cinque giorni di viaggio attraverso gli Urali, la famiglia e i trentanove membri del
suo seguito si imbarcarono su un piroscafo a Tjumen, e passarono davanti alla
casa di Rasputin a Pokrovskoe.
‘Si
radunarono sul ponte per vedere la dimora dello starec’.
Le ragazze
indossavano ancora medaglioni con il suo ritratto. Giunsero a Tobolsk l’indomani
sera, e rimasero a bordo mentre veniva preparato per loro il palazzo a due
piani del governatore rinominato ‘Casa della Libertà’. La famiglia si sistemò
al primo piano, con le ragazze che condividevano una camera d’angolo, i genitori
che avevano per sé una camera, uno studio, un salotto e un bagno, e Alessio e l’ex
marinaio Nagornyj che dividevano una stanzetta.
A
Pietrogrado, il 25 ottobre 1917, presero il potere i
bolscevichi.
‘Una seconda
rivoluzione’ scrisse tre giorni dopo l’ex zarina. I tedeschi avanzarono sulla
Russia, e Lenin, il leader dei bolscevichi, decise immediatamente di ritirarsi
dal conflitto, il che mandò su tutte le furie Nicola:
‘Come hanno potuto, quei mascalzoni, avere la
sfrontatezza di portare avanti il loro sogno segreto di proporre la pace al nemico?’.
Ciò rafforzò
la sua convinzione che esistesse una congiura ebraica su scala internazionale.
‘Ho iniziato a leggere a voce alta il libro di
Nilus sull’Anticristo a cui si sono aggiunti i Protocolli degli ebrei e dei
massoni (i Protocolli dei Savi di Sion ): una lettura assai attuale’.
Nello scrivere a sua sorella Ksenija, il 5 novembre, elencava una lista di rivoluzionari con il corrispettivo vero nome ebraico, sostenendo che Lenin fosse in realtà un Cederbljum e Trockij un Bronštejn. Sul secondo aveva ragione, mentre il primo era nato con il cognome Uljanov.
‘È peggio e più vergognoso’
…pensava
‘che al tempo dei Torbidi’.
Nel febbraio 1918 il gelo dei bolscevichi
calò sulla famiglia. Le amichevoli guardie vennero sostituite da ‘una banda di
giovanotti con l’aspetto di canaglie’. Il fragile regime di Lenin stentava a
sopravvivere. Il commissario per gli Affari esteri Lev Trockij negoziò la pace,
mentre l’esercito del Kaiser penetrava sempre più a fondo in territorio russo.
‘La madrepatria
socialista è in pericolo’ avvertiva Lenin, e va difesa fino ‘all’ultima goccia
di sangue’. I nemici andavano ‘fucilati sul posto’. Più aumentava la crisi del
regime, maggiori erano i rischi per i Romanov.
Mentre
Nicky e Alix corrispondevano con gli amici di Pietrogrado, come Anna, e con i
familiari in Crimea, alcune fazioni bolsceviche tentarono di assaltare la Casa della Libertà per ucciderli.
Gli
ufficiali zaristi escogitarono piani per salvarli. Ciò mise Lenin in allarme.
Il 1° aprile Jakov Sverdlov, presidente del Comitato
esecutivo centrale e segretario del partito, il principale accolito di Lenin,
esile, bruno, con folti capelli neri, lenti rotonde e una voce profonda che gli
era valsa il soprannome di ‘Tromba’, rafforzò il corpo di guardia a Tobolsk e
decise di trasferire la famiglia a Mosca.
I
bolscevichi avevano appena ristabilito il governo al Cremlino.
Lenin aveva
intenzione di processare pubblicamente Nicola e Trockij si era proposto come
pubblico ministero. Alcuni giorni dopo, Sverdlov mandò Vasilij Jakovlev, figlio
di contadini e navigato rivoluzionario, al comando di un Distaccamento a
destinazione speciale di centocinquanta Guardie Rosse, con l’incarico di
trasferire
‘Nicola negli Urali. Riteniamo che per
il momento dobbiate farlo stabilire a Ekaterinburg’.
I bolscevichi degli Urali erano in disaccordo quanto i vertici di Mosca su cosa fare del’ex zar, ma ben sapendo che alcuni degli elementi locali volevano ucciderlo immediatamente, Sverdlov specificò:
‘Il compito di Jakovlev è condurlo a
Ekaterinburg vivo’
…per
consegnarlo al quarantaduenne Gološčëkin, fidato membro del Comitato centrale
nominato da lui e Lenin a capo degli Urali e noto come ‘l’occhio del Cremlino’.
Le loro più
recondite intenzioni restano tuttora ignote. L’ipotesi più probabile è che
volessero trasferire Nicola a Mosca ma, data la crisi, avessero scelto di parcheggiare
‘per il momento’ i Romanov a Ekaterinburg dove, nel dubbio, avrebbero anche
potuto farli uccidere.
Lenin e
Sverdlov non temevano uno spargimento di sangue.
Il
nichilista Nečaev si era chiesto:
‘Che membro della dinastia reale va annientato? L’intera
stirpe’.
E questa
sua osservazione aveva deliziato Lenin:
‘È di una semplicità al limite del geniale’.
Era
convinto che ‘una rivoluzione senza plotoni d’esecuzione è priva di senso’ e in
un saggio del 1911 aveva sostenuto che
‘se in un paese colto come l’Inghilterra è
necessario decapitare un solo criminale incoronato in Russia bisogna decapitare
almeno un centinaio di Romanov’.
Lenin e Trockij avevano firmato a Brest-Litovsk un trattato di pace con la Germania che cedeva l’Ucraina e gli Stati del Baltico a dei regimi fantoccio, controllati dal trionfante Kaiser.
‘Immagino
che vogliano costringermi a siglare l’accordo’
…disse
Nicola.
‘Ma piuttosto mi farei tagliare una mano’.
…e
Alessandra temeva che,
‘lasciato solo, farà qualcosa di stupido come già
in passato. Se non ci sono io, possono convincerlo a fare ciò che vogliono’.
Alle otto e quaranta di mattina del 30 aprile giunsero nella stazione di
Ekaterinburg dove una folla urlante Impiccateli!
li attendeva pronta a linciare lo zar. Jakovlev fece spianare i fucili e si
rifiutò di consegnarli. Dopo tre ore di stallo Gološčëkin guidò un corteo per
accompagnare il Bagaglio nella sua nuova residenza, un edificio confiscato a un
ingegnere del posto, Nikolaj Ipatev, e ora rinominato Casa a destinazione
speciale.
Intorno all’edificio
avevano già costruito un’alta recinzione. All’arrivo, il 17 aprile, avevano
dovuto subire una minuziosa perquisizione di tutti i loro bauli.
‘A quel punto sono sbottato’
…scrisse
Nicola.
Rendendosi
conto che stavano entrando in una nuova e pericolosa fase, Alessandra disegnò
sul davanzale come portafortuna il suo segno talismano, la svastica.
Ne avrebbe avuto
bisogno.
Alla
stazione, il principe Valja Dolgorukij venne separato dal gruppo e in seguito
arrestato: aveva con sé mappe e contante e chiaramente progettava una fuga
della famiglia.
Il Soviet
della regione degli Urali si rifiuta categoricamente di assumersi la
responsabilità del trasferimento di Nicola Romanov alla volta di Mosca e
ritiene necessario liquidarlo. Sussiste il grave pericolo che il cittadino Romanov
possa cadere nelle mani dei cecoslovacchi e di altri controrivoluzionari. Non
possiamo venir meno al nostro dovere nei confronti della Rivoluzione. La
famiglia Romanov deve anch’essa venir liquidata.
Il 16 luglio, ‘mattinata grigia, più tardi un bel sole’,
Alessio era ‘lievemente raffreddato’ scrisse Alessandra, ma ‘siamo tutti usciti
per una mezz’ora’. Poi ‘io e Olga abbiamo sistemato i medicinali’, la frase in codice
con cui si riferivano ai gioielli, che indica come fossero pronti a un trasferimento
improvviso.
‘Il Comandante Bue [Jurovskij] entra nelle nostre
stanze, almeno ha portato di nuovo delle uova per Baby’.
Jurovskij ordinò dalla rimessa militare un camioncino Fiat per trasportare i cadaveri. Alle sei meno dieci del pomeriggio Filipp Gološčëkin telegrafò a Lenin e Sverdlov a Mosca tramite Grigorij Zinovev, il capo del Soviet di Pietrogrado (perché le comunicazioni erano sempre meno affidabili):
‘Fate sapere a Mosca che per ragioni di
ordine militare il processo concordato con Filipp [Gološčëkin] non può più
essere rinviato. Non possiamo aspettare. Qualora foste di un avviso diverso
notificatecelo immediatamente. Gološčëkin’.
‘Processo’
era il nome in codice per esecuzione; i destinatari del telegramma dimostravano
che l’assassinio era stato discusso ai massimi vertici, e dal suo tono emerge
come Mosca avesse lasciato a Ekaterinburg la facoltà di prendere la decisione
finale. Jurovskij avrebbe ricordato che un telegramma del Centro aveva dato l’assenso,
ma quel messaggio non è mai stato rinvenuto.
Gološčëkin
e Beloborodov convocarono il terrificante Ermakov e gli annunciarono:
‘Siete un
uomo fortunato. Siete stato scelto per giustiziarli e seppellirli in modo che nessuno
possa mai più trovarne i corpi’.
ZAR ROSSI & BIANCHI
Quando
dissero allo zarevič Alessio che il padre aveva abdicato, il ragazzo chiese: ‘Chi
governerà la Russia?’.
Marx
ha scritto che la storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la
seconda come farsa. È un’osservazione arguta, ma lontana dalla verità.
La storia
non si ripete mai, piuttosto prende in prestito, ruba, riecheggia e requisisce
ciò che è stato, in modo da creare un ibrido, qualcosa di unico che riunisca in
sé gli elementi del passato e del presente. Dal 1917 in poi nessuno zar avrebbe più regnato sulla Russia, ma
ognuno dei successori di Nicola, chiamati a governare lo stesso impero con
molte delle medesime difficoltà in circostanze del tutto diverse, ha
canalizzato, adattato e riplasmato il prestigio dei Romanov allo Zeitgeist del
proprio tempo.
A
Brest-Litovsk, Lenin aveva perso l’Ucraina, il Caucaso e molto altro. E senza l’Ucraina
la Russia avrebbe cessato di essere una grande potenza. Alla fine, però, riuscì
astutamente a ricomporre l’impero dei Romanov, perdendo solo la Finlandia, la
Polonia e gli Stati del Baltico.
Lo stesso
Stalin, mentre scavalcava i suoi rivali per succedere a Lenin, segretamente
riteneva che la Russia avesse bisogno di uno zar: nell’aprile 1926 rifletteva che,
malgrado il governo del partito,
‘la gente ne capiva ben poco. Per secoli, in
Russia, la gente è stata soggetta a uno zar. I russi sono zaristi abituati al
fatto che ci sia un capo. E ora dovrebbe essercene uno’.
Studiò in particolare Ivan il Terribile e Pietro il Grande.
‘Il popolo ha bisogno di uno zar’
disse negli
anni Trenta.
‘Uno zar da adorare, uno zar per cui vivere e
lavorare’.
Plasmò con
cura la propria immagine per dare vita a un nuovo modello di zar, paterno e
misterioso, industriale e urbano, capo di una missione internazionalista e al
tempo stesso monarca di tutti i russi. Mentre i tedeschi avanzavano, nel 1941, studiò il 1812 e nel 1942-43 tirò fuori i ranghi, i
galloni dorati e le spalline ed esaltò eroi dell’epoca zarista come Kutuzov e
Suvorov. Il suo regime di terrore gli permise di attuare radicali inversioni di
politica, come il patto con Hitler, di sopravvivere a colossali disastri
autoinflitti e di costringere i russi a immani sacrifici.
La sua
autorità personale, la sua violenza omicida, la sua propaganda
marxista-nazionalista, l’industrializzazione sfrenata e l’economia del comando
implicavano per lui la possibilità di poter sfruttare risorse che per Nicola
sarebbero state inimmaginabili.
Stalin fu
un tiranno sanguinario e l’esperienza sovietica una tragica distopia per i russi,
eppure quell’uomo trascese gli zar, sconfisse la Germania e lasciò la Russia
regista dell’Europa orientale e superpotenza nucleare.
Si
paragonò sempre ai Romanov.
Nel 1945, quando l’ambasciatore americano Averell Harriman si congratulò con lui per la presa di Berlino, lui lo rimbeccò:
‘Sì, ma Alessandro I ce l’ha fatta con Parigi’.
Nel 1991 lo smembramento dell’Unione Sovietica corrispose
anche al disintegrarsi dell’impero dei Romanov che Lenin e Stalin avevano
tenuto insieme con astuzia e forza. L’autentica scaltrezza alla base della loro
federazione delle quindici repubbliche aveva finito per ritorcersi contro quei marxisti
imperialisti, dal momento che non c’era mai stata l’intenzione di rendere
quelle repubbliche indipendenti. Ma Boris Eltsin, il nuovo leader della
Federazione russa, aveva fatto leva sulle aspirazioni delle repubbliche per
scalzare il presidente sovietico Michail Gorbačëv e smantellare l’URSS.
Milioni di
russi si ritrovarono in nuove nazioni, mentre i sacri territori slavi l’Ucraina
o la Crimea venivano sacrificati sull’altare
della Madre Patria. L’Occidente decadente e liberale osava spingere la propria
influenza fino alle nuove repubbliche Ucraina, Georgia, Estonia proprio a
ridosso dei confini della Russia.
Eltsin creò quella che sarebbe stata a eccezione delle
elezioni abortite del 1917 la prima vera democrazia russa, con una stampa
libera e un mercato libero. Al pari degli zar prima di Paolo I, fu lui stesso a scegliere il suo successore, Vladimir
Putin, un ex colonnello del KGB convertitosi alla politica, per
proteggere la sua famiglia e la sua eredità.
La prima missione di Putin fu quella di riaffermare la potenza della Russia sia in patria sia all’estero. Nel 2000 la sua guerra cecena fece in modo che la Federazione russa restasse unita. Nel 2008 un conflitto con la Georgia, una delle repubbliche più occidentalizzate, ristabilì l’egemonia russa sul Caucaso. Nel 2014 il tentativo da parte dell’Occidente di attrarre l’Ucraina nel proprio sistema economico ha indotto Putin ad approfittarne, avviando una guerra che gli ha consentito di appoggiare una lotta di secessione in Ucraina orientale e di annettere la Crimea, che egli considerava il ‘nostro Monte del Tempio’.
Ha
chiamato la sua ideologia ‘democrazia sovrana’, con una chiara enfasi sul
concetto di sovranità: il putinismo ha infatti fuso tra loro autoritarismo dei
Romanov, sacralità ortodossa, nazionalismo russo, capitalismo clientelare,
burocrazia sovietica e istituti della democrazia come elezioni e parlamenti. Se
un’ideologia c’è stata, si è caratterizzata per l’acredine e il disprezzo nei
confronti dell’America e per la nostalgia dell’Unione Sovietica e dell’impero
dei Romanov, ma il suo spirito intrinseco era improntato al culto dell’autorità
e al diritto di arricchirsi servendo lo Stato.
La missione
slavofila di nazione ortodossa, superiore all’Occidente e di carattere
eccezionale, ha rimpiazzato quella dell’internazionalismo marxista. Mentre il
patriarca ortodosso Kirill ha definito Putin un ‘miracolo di Dio’ per la
Russia, il presidente stesso vede nel ‘popolo russo il fulcro di un’opera di
civilizzazione unica’.
Pietro il Grande e Stalin sono entrambi visti come gloriosi esempi di governanti russi. La Russia di oggi è erede di entrambi, una fusione di stalinismo imperiale e autoritarismo digitale tipico del XXI secolo, intralciata e corrotta dal suo capriccio personale, dall’atavica assenza di legalità, dalla paralisi economica e dalla corruzione elefantiaca, sebbene ammantata di modernità.
Guardando
ai quattro secoli di storia russa è curioso notare come in Russia ogni periodo
dei Torbidi 1610-13, 1917-18 e 1991-99
sia culminato in una nuova versione della vecchia autocrazia, agevolata dai
costumi e dalle tradizioni del predecessore caduto, e giustificata dall’urgente
necessità di ristabilire l’ordine, attuare una modernizzazione radicale e
riguadagnare alla Russia il suo posto tra le grandi potenze.
Putin
governa secondo lo schema dei Romanov: con l’autocrazia e il potere nelle mani
di una minuscola cricca in cambio della garanzia di prosperità in patria e
rispettabilità all’estero. Il conte Valuev, ministro di Alessandro II,
ironizzava sul fatto che ci fosse ‘un che di erotico’ nelle avventure nelle
lontane terre esotiche, e ciò vale certamente per gli exploit militari russi in
Medio Oriente, uno spettacolo in termini televisivi. Ma come gli ultimi zar
hanno scoperto a loro spese, la riuscita di questo azzardo dipende dal successo
economico.
Al contrario
degli zar, però, Putin ha dalla sua l’ultima risorsa delle armi nucleari.
Nel suo eccezionalismo russo, nel suo orgoglio imperialista, nel suo conservatorismo in patria, nel suo stile individualistico di governo, nel successo delle sue attività aggressive in ambito internazionale, Putin assomiglia moltissimo allo zar Nicola I con la sua politica di Ortodossia, Autocrazia, Nazionalità. Nei suoi venticinque anni di regno, anche Nicola dominò ed ebbe la meglio sulle potenze occidentali. Solo la guerra la disfatta in Crimea riuscì a fermarlo. Ma è con il padre di Nicola II, Alessandro III, il quale mise fine alla riforma liberale, che Putin più si identifica.
Gli oscuri
intrallazzi di potere attorno a un unico uomo nel Cremlino del XXI secolo di
certo richiamano quelli che coinvolsero gli imperatori dei Romanov.
Putin è
senza dubbio un governante abile e opportunista, che ha posto di nuovo la
Russia al centro della scena mondiale trascurando al contempo le riforme. La
sua autocrazia gli consente, per la sua stessa natura, di prendere quel genere
di decisioni rapide che oggi risultano impossibili nelle divise e tremebonde
democrazie occidentali.
Tale tracotanza
gli ha procurato l’ammirazione di quanti, in Occidente, si sentono frustrati
dalla debolezza della democrazia: Donald Trump,
vincitore nel 2016 delle elezioni
presidenziali statunitensi che si autopromuove come una specie di zar
americano, ha proclamato il proprio rispetto nei confronti di Putin per gli
indiscutibili successi come leader mondiale e autocrate spietato. Entrambi si
gloriano della propria concretezza, ma le realtà del potere potrebbero un
giorno arrivare a testarne la stima reciproca.
Il suo entourage ha soprannominato Putin lo ‘zar’, ma non è il pensiero dei grandi Romanov a tenerlo sveglio la notte, quanto piuttosto il ricordo di Nicola II. Una sera, nel Palazzo di Novo-Ogarëvo, la sua residenza principale nei pressi di Mosca, Putin ha chiesto ai suoi seguaci chi fossero, a loro avviso, i ‘peggiori traditori’ della Russia. Prima che potessero rispondergli, li ha anticipati: ‘I peggiori criminali della nostra storia sono stati i deboli che hanno gettato il potere alle ortiche Nicola II e Michail Gorbačëv consentendo che se ne impadronissero isterici e folli’.
E ha concluso
promettendo:
‘Io non
abdicherò mai’.
I Romanov non ci sono più, ma le pastoie dell’autocrazia russa esistono tuttora.
(S. Montefiore)
LA FRECCIA DEL TEMPO? (assenza di Filosofia dal Filosofo di Stato, ovvero nasce la QUARTA MARCIA…)
È assolutamente possibile che la Russia possa
conoscere di nuovo il feudalesimo, o perfino una società in cui viga la
schiavitù, o magari l’emersione di una società comunista o primordiale. Coloro
che si burlano di queste ipotesi sono prigionieri della modernità ipnotica.
Riconoscendo la reversibilità del tempo storico-politico, siamo approdati a un
nuovo punto di vista pluralistico per la scienza politica, e abbiamo raggiunto
la prospettiva avanzata necessaria per una nuova costruzione ideologica.
La
Quatta Teoria Politica
è una teoria non moderna. Parafrasando Bruno Latour ‘Non siamo mai stati
contemporanei’. Gli assiomi teorici della modernità sono innocui perché non
possono essere realizzati nella realtà. In pratica, si negano da soli in
maniera permanente e spettacolare.
La
Quarta Teoria Politica
scarta completamente l’idea dell’irreversibilità della storia. Questa idea era
interessante in senso speculativo, come è stato argomentato da Georges Dumézil
con il suo anti-evemerismo, nonché da Gilbert Durand.
Il tempo è
un fenomeno sociale, le sue strutture non dipendono da caratteri oggettivi ma
dall’influenza dominante sui paradigmi sociali, perché l’oggetto è assegnato
dalla società stessa. Nella società moderna, il tempo è considerato
irreversibile, progressivo e unidirezionale, ma ciò non è necessariamente vero
all’interno di società che non accettano la modernità. In certe società, in cui
manca una rigida visione moderna del tempo, esistono concezioni cicliche e
perfino regressive del tempo.
Quindi, la
storia politica è considerata dalla Quarta Teoria Politica
nel contesto della topografia di una pluralità di concezioni del tempo.
Ci sono
tante concezioni del tempo quante società.
La
Quarta Teoria Politica
non mette solo da parte il progresso e la modernizzazione, comunque. Questa
teoria contempla un progresso e una modernizzazione relative, intimamente
connesse con certe occasioni semantiche storiche, sociali e politiche del
momento presente, come nella teoria occasionalista.
La
Quarta Teoria Politica
adotta un concetto di tempo reversibile correlato alle società. Nel contesto
della modernità, ritornare da un momento storico a un momento storico
precedente è impossibile, ma è possibile nel contesto della Quarta Teoria
Politica.
La
Quarta Teoria Politica
adotta un concetto di tempo reversibile correlato alle società. Nel contesto
della modernità, ritornare da un momento storico a un momento storico
precedente è impossibile, ma è possibile nel contesto
della Quarta Teoria Politica.
L’idea di
Berdjaev del ‘Nuovo Medioevo’ è fondata, le società possono essere variamente
costituite e trasformate. L’esperienza degli
anni ’90 lo dimostra bene: il popolo dell’URSS era convinto che il
socialismo si sarebbe originato dal capitalismo, e non viceversa, ma negli anni
90 si è verificato il contrario: il capitalismo ha seguito il socialismo.
È assolutamente possibile che la Russia possa conoscere di nuovo il feudalesimo, o perfino una società in cui viga la schiavitù, o magari l’emersione di una società comunista o primordiale. Coloro che si burlano di queste ipotesi sono prigionieri della modernità ipnotica. Riconoscendo la reversibilità del tempo storico-politico, siamo approdati a un nuovo punto di vista pluralistico per la scienza politica, e abbiamo raggiunto la prospettiva avanzata necessaria per una nuova costruzione ideologica.
(A. Dugin)
E con quest’ultima affermazione mi congedo dall’eminente filosofo di Stato, Stato abdicato alla tirannia di cui ogni più certo Filosofo ne ha combattuto l’insano morbo!
Dato che nelle leggi classiche non esiste una
freccia che assegni una direzione al tempo, un’istruzione che dica - da usarsi
solo in questo senso e non in quello opposto - viene spontaneo chiedersi la
seguente cosa: se le leggi che governano l’esperienza considerano entrambi gli
orientamenti temporali in modo simmetrico, perché le esperienze sono tanto
sbilanciate in una direzione temporale, perché si verificano sempre in un senso
ma non nell’altro?
Da dove ha origine la direzionalità del tempo che
osserviamo e percepiamo?
Se trattiamo di sistemi evolutivi (viventi),
possiamo introdurre un terzo concetto: l’indeterminazione termodinamica,
collegata al carattere intrinsecamente irreversibile del tempo.
L’indeterminazione termodinamica nasce dall’esistenza sperimentale della
freccia del tempo e dell’evidenza sperimentale che, durante la misura il tempo
scorre.
Recentemente gli astrofisici hanno scoperto che la massa di una stella è collegata al tempo di vita della stella stessa. Maggiore è la massa, minore è il tempo di vita.
(E.Tiezzi, da Giuliano, L’Eretico Viaggio)
















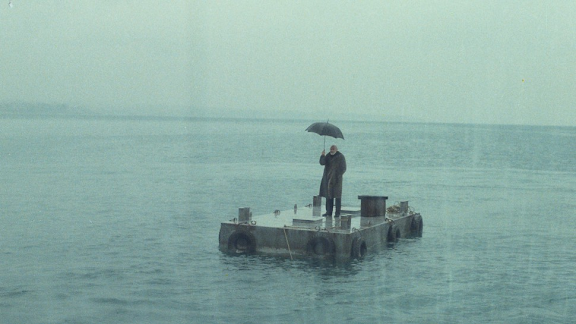
.gif)


.gif)















